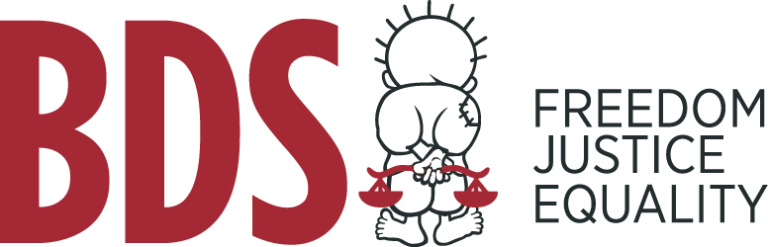Quando ti ho visto – il ritorno, oggetto della partenza
Autrice stringata ma di tutto rispetto, Annemarie Jacir è tra i migliori registi palestinesi contemporanei. Divenuta famosa per essere stata la prima regista donna palestinese ad aver diretto un lungometraggio, lo splendido Il sale di questo mare, col suo secondo film, dal titolo Quando ti ho visto, conferma il suo immenso talento e la sua capacità narrativa.

Giordania, 1967, dopo la fallimentare esperienza araba nella Guerra dei sei giorni, molti sono i profughi che devono abbandonare la Palestina, Tarek è tra questi. Il ragazzino, durante i giorni di conflitto, è stato costretto a abbandonare il padre nella terra natia per partire con la madre alla ricerca di un futuro in Giordania. I due fuggitivi però finiscono a vivere in un campo profughi nella nuova patria, terra capace di sopportarli ma mai accoglierli.
Il campo, le difficoltà di inserimento nel nuovo contesto e la mancanza del padre, alienano progressivamente Tarek che decide, da solo, di fare ritorno a casa e si incammina verso il confine con la Palestina.
Inizia così il viaggio del protagonista verso il confine che separa la Giordania dalla sua Palestina. Un viaggio alla ricerca di un futuro idealizzato, un futuro che si intreccia e si confonde con il passato del bambino e con l’idealizzazione della patria perduta. Mentre la madre lo cerca disperatamente, temendo che la sua fuga possa averlo portato alla morte, Tarek si imbatte in un fidā’ī, che lo soccorre e lo conduce dai suoi compagni d’arme: i Fedayyìn, combattenti che si oppongono tramite una guerra di guerriglia a Israele. Qui, tra i miliziani che si addestrano per attaccare Israele, inizia la seconda vita di Tarek: quella capace di trasformarlo in parte integrante del gruppo militare, di renderlo la mascotte dei combattenti per la patria perduta, quei partigiani pronti a sacrificare la propria vita per la Palestina e desiderosi di farvi ritorno in un prossimo futuro. Combattenti dal destino mozzato come Tarek.
Il film prosegue narrando la vita del bambino, e della madre, che finalmente riesce a raggiungere il figlio, assieme al gruppo di combattenti. Tuttavia, la ricerca del protagonista di una famiglia, seppur inizialmente sembra essere compensata dalla presenza dei militari, ben presto lascia spazio al desiderio di ricongiungersi alla patria perduta e al padre di cui non si conosce il destino.

Il lungometraggio si focalizza così sul continuo senso di inadeguatezza (soprattutto di Tarek ma non solo) causato dalla ferita infetta di un dramma irrisolto. Attraverso una metafora abusata ma sempre molto potente, soprattutto se utilizzata abilmente come fa Jacir, la storia di Tarek diventa la storia del popolo palestinese: un bambino privato del padre e un popolo privato della patria, con le due assenze che tendono a convergere in una sola greve mancanza. Il racconto diventa quindi la storia di un popolo privo di una casa, alla continua ricerca di una pace inesistente: la storia di partigiani inebriati da un mito sfuggente come la lieve brezza che filtra tra i rami dei boschi giordani.
I film di Jacir raccontano storie di persone comuni che si trovano ad affrontare situazioni complesse. Storie di vita quotidiana che ambiscono all’universale: sullo sfondo, infatti, è sempre presente il dramma della Palestina e dei suoi abitanti, un dramma che dalla cinepresa di Jacir appare senza possibilità di risoluzione.
Il finale del film, tra uno splendido e rocambolesco ricongiungimento familiare e l’incertezza della sorte dei personaggi lungo il confine tanto desiderato è l’esempio dell’eterna precarietà di un popolo che vive nel passato, è incerto nel presente e forse senza futuro.
Luigi Toninelli